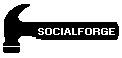Ramor Ryan è uno scrittore e traduttore che ha vissuto per quasi due decenni in Chiapas, Messico, dove ha assistito e partecipato alla lotta rivoluzionaria degli zapatisti. Il suo primo libro Clandestines: The Pirate Journals of an Irish Exile (2006) – una raccolta di scritti dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni Duemila – è stato lodato come un raro documento di dissenso, che rifiuta il cinismo e l’amnesia prevalenti durante i primi giorni della cosiddetta fine della storia. Nel 2011 è seguita la sua seconda opera Zapatista Spring: Anatomy of a Rebel Water Project & the Lessons of International Solidarity, che racconta la sua esperienza nella costruzione di un sistema di approvvigionamento idrico – uno dei numerosi progetti di questo tipo in cui è stato coinvolto in quel periodo – con un gruppo eterogeneo di volontari della solidarietà internazionale in un remoto villaggio della giungla lacandona. Il libro è uno dei resoconti più realistici delle lotte quotidiane degli zapatisti e dei tentativi dei radicali internazionali di impegnarsi e sostenere il movimento. Offre numerosi spunti di riflessione sulle tensioni, le contraddizioni e le occasionali assurdità del lavoro di solidarietà internazionale; in questo caso, l’abisso materiale e culturale tra gli attivisti della solidarietà, per lo più occidentali, e la comunità locale del Chiapas.
Sebbene la conversazione si rivolga in seguito al movimento per la libertà dei curdi, al contropotere in Europa, alla politica dei movimenti sociali in America Latina e alle iniziative di autodifesa comunitaria in Messico, l’attenzione principale si concentra sulle esperienze di Ramor in Chiapas e altrove in America Latina durante gli anni Novanta e Duemila e sulle sue idee sulla pratica della solidarietà internazionale. Il compito di generare lotte rivoluzionarie attraverso le divisioni della disuguaglianza globale è più urgente che mai e le sfide e le lezioni dello zapatismo sono in corso.
Introduzione e intervista di Liam Hough.
Liam Hough: Può raccontare brevemente come si è avvicinato alla scrittura e alla politica e cosa l’ha portata in Chiapas?
Ramor Ryan: Da giovane ero un lettore accanito, da Camus a Orwell, e questo ha informato la mia risposta alle condizioni materiali: entrambi i miei genitori sono morti di malattia in seguito ad anni di difficoltà economiche durante la mia adolescenza – e io sono stato avviato a un percorso di ribellione. All’università sono stato fortemente coinvolto nella politica studentesca e sono diventato redattore del giornale del Trinity College Student’s Union, che in qualche modo sono riuscito a convertire da organo politico serio in una sorta di punkzine. Suppongo che aver fatto parte di una folla di persone in lutto attaccate dal lealista Michael Stone con mitragliatrici e granate in un cimitero di Belfast nel 1988 mi abbia fatto capire la serietà dell’impegno politico. Più tardi, nello stesso anno, andai a vivere a Berlino Ovest e fui completamente attratto dal movimento autonomo, con i suoi squat e la comunità alternativa. Sono tornato a Berlino per tutti gli anni ’90 dopo la caduta del Muro, vivendo nella vivace scena degli squat di Berlino Est.
Ho vissuto gli ultimi sei mesi della Rivoluzione Sandinista in Nicaragua, prima che venissero cacciati dal potere nel febbraio del 1990. Raccogliendo caffè in una cooperativa rurale e insegnando inglese in un’università sandinista, mi sono fatta strada come volontaria della solidarietà internazionale. All’inizio degli anni ’90 mi sono addentrato nel tumultuoso spazio politico dell’America Latina, impegnandomi in campagne anticapitaliste contro lo sfruttamento delle multinazionali in Colombia e per il riconoscimento sindacale dei lavoratori delle banane in Belize. Quando gli zapatisti sono emersi nel 1994, ero pronto e preparato e mi sono buttato nella lotta per i due decenni successivi.
Come descriverebbe l’impatto dell’improvviso emergere degli zapatisti nel 1994, sia per la sinistra occidentale in generale che per lei personalmente? Qual era il contesto politico?
Il contesto era quello del crollo dell’Unione Sovietica e della caduta del Muro di Berlino nel 1989-90, e della presunta fine della storia e delle rivoluzioni: il neoliberismo capitalista aveva vinto. Poi, il 1° gennaio 1994, gli zapatisti si sono sollevati in Chiapas, Messico, e improvvisamente la storia si è rimessa in movimento.
Divenne subito chiaro che si trattava di un nuovo tipo di insurrezione latina che superava la camicia di forza ideologica dell’era della Guerra Fredda e abbracciava una formulazione completamente nuova di come iniziare una rivoluzione. Il Subcomandante Marcos era in piedi nella piazza di San Cristóbal e parlava di una forma di liberazione più illuminata di quella che era stata articolata in precedenza. Era sparito il vecchio linguaggio leninista e, come imparammo presto, i modi di organizzazione. Un esercito di guerriglieri contadini apparentemente antiautoritario che si sollevava contro un accordo commerciale internazionale neoliberale: questa era una rivoluzione di cui potevo far parte. La loro politica emancipatoria, l’orizzontalità e la lotta per l’autonomia riecheggiavano con i progetti politici della scena autonoma europea e sembrava che ci fosse una linea politica diretta dagli squat di Berlino alla giungla del Lacandona.
La rivolta zapatista allora stava sbocciando, traboccava di possibilità. Sembrava davvero che un nuovo mondo fosse non solo possibile, ma anche dietro l’angolo. Migliaia di persone arrivarono in Chiapas da altre parti del Messico e da tutto il mondo per partecipare. C’era una reale sensazione di cambiare la storia, di essere parte di un momento rivoluzionario, di trasformazione.
Il Subcomandante Marcos durante un incontro pubblico dell’EZLN, La Realidad, Chiapas 1999. Foto: cesar bojorquez / Flickr
Dopo il ’94 furono organizzati grandi incontri, encuentros. Prima di tutto nella giungla del Lacandona in Chiapas e poi in diversi luoghi del mondo; ad esempio a Belém, in Brasile, che riunì migliaia di persone provenienti da tutte le Americhe. È stata un’esperienza fenomenale, l’atmosfera era elettrica e si è creato un raro senso di unità tra la sinistra radicale.
Il movimento zapatista confluì in altre iniziative come People’s Global Action, un coordinamento mondiale di movimenti sociali radicali che fu fondamentale per organizzare l’ondata di proteste e rivolte contro la globalizzazione, da Seattle nel ’99 a Genova nel 2001.
Ricordo di aver marciato esultante lungo la collina di Genova. C’erano più di 100.000 manifestanti quel fine settimana; intorno c’erano persone che conoscevo dal Chiapas e lo spirito dello zapatismo predominava. Pensavo: “Stiamo vincendo”. Naturalmente, in quel momento le autorità hanno iniziato a sparare.
Come vede il movimento zapatista oggi? Quali sono, secondo lei, i loro principali risultati? Di recente, sono stati loro a viaggiare per andare a trovare i compagni lontani con il “Viaggio per la vita – Capitolo europeo”.
Materialmente, l’impatto maggiore della rivolta zapatista si è avuto nella distribuzione delle terre, con la spartizione dei vecchi latifondi aristocratici e la disintegrazione del vecchio ordine nell’entroterra del Chiapas. Nuove relazioni sociali e di proprietà radicali hanno sostituito il vecchio ordine e, contro ogni previsione, la nuova visione radicale sta resistendo. È impressionante. Terra e libertà realizzate, anche se a livello locale.
Al di là del materiale, la ribellione zapatista ha incoraggiato le persone a fare le cose da sole. Quando si parla con gli zapatisti sul campo, c’è sempre il prima e il dopo dell’essere diventati zapatisti: il prima dell’obbedienza e della passività e il dopo della consapevolezza del loro reale potere e delle loro capacità. Questo si manifesta concretamente nell’autogoverno della regione. Gli zapatisti possono organizzare il proprio territorio autonomo, i bisogni educativi e sanitari, l’economia e l’autogoverno grazie alla partecipazione attiva di decine di migliaia di persone in Chiapas, che lavorano collettivamente.
Questo è forse il più grande risultato dell’insurrezione zapatista: esistere ancora e detenere un territorio di cui possono veramente dire di avere il controllo, che è la loro regione autonoma. Nonostante tutto quello che gli è stato gettato addosso, sopravvivono e prosperano, arrivando persino a inviare emissari in tutto il mondo per parlare delle loro conquiste. Non è un’utopia, ha molti problemi, ma è qualcosa che vale la pena celebrare e difendere. Dimostra nel suo piccolo, per quanto remoto e unico appaia, che altri modelli sono possibili, che le cose possono essere diverse.
Mi è piaciuta l’audacia della loro “riconquista” dell’Europa e il loro grido di resistenza “Siamo ancora qui a resistere!” dopo 500 anni di colonizzazione europea. Organizzare un tour durante l’era del COVID-19 sarebbe stato sempre un incubo burocratico e logistico, ma il “Viaggio per la vita, capitolo europeo” degli zapatisti ha avuto molto successo, servendo a consolidare le loro basi di sostegno in Europa, aumentando il loro profilo internazionale e inviando un messaggio allo Stato messicano che gli zapatisti possono ancora contare su un sostegno globale.
Sul terreno in Chiapas, gli zapatisti stanno affrontando crescenti minacce paramilitari, oltre alle onnipresenti pressioni delle autorità regionali. L’esercito messicano è ancora schierato in tutta la zona autonoma e ora c’è una nuova ondata di sconfinamento dei cartelli della droga nel sud del Messico che sta generando più violenza e sfidando il controllo zapatista in alcune aree. Rompendo efficacemente l’accerchiamento in Chiapas e portando un grande contingente di zapatisti in giro per il mondo ad agire come ambasciatori di base, si cambia la correlazione di forze; anche il fatto che la maggior parte dei giovani zapatisti che sono venuti in Europa come parte della delegazione siano cresciuti per tutta la vita in una zona liberata è fonte di ispirazione.
Lei è stato coinvolto in Chiapas molto presto in termini di lavoro di solidarietà. Potrebbe parlare dei diversi modelli o fasi della solidarietà internazionale che hanno fatto parte di questa esperienza?
Innanzitutto, c’è la solidarietà internazionale dall’alto e quella dal basso. Dal basso significa solidarietà rivoluzionaria con gli oppressi. Non si tratta di un’azione virtuosa, ma di un’azione concreta, che consiste nel percorrere il cammino con i compagni. Per molti versi, “solidarietà internazionale” non è un termine utile, poiché viene spesso utilizzato per qualsiasi tipo di intervento statale o delle Nazioni Unite su larga scala, per cui alcuni preferiscono il termine internazionalismo, o talvolta intercomunitario.
In secondo luogo, in teoria, la solidarietà internazionale a cui aspiriamo è una strategia o un insieme di pratiche politiche che cercano di trasformare radicalmente le relazioni di potere tra le persone al di là dei confini nazionali e statali. Per gli antiautoritari, questo comporta un’orizzontalità di relazioni che è sia il mezzo che l’obiettivo. Non si tratta quindi di carità, né di fornire una rete di sicurezza in assenza di infrastrutture governative. Si tratta di una trasformazione politica e sociale.
In terzo luogo, il processo di solidarietà internazionale è, come la rivoluzione, una domanda e non una risposta e diventa un’esplorazione nella creazione di dignità. Inteso in questo modo, praticare la solidarietà non è solo sostenere una causa, ma anche un tentativo di forgiare e ricreare continuamente una nozione di umanità condivisa, una base per la sopravvivenza comune.
Come dicono gli zapatisti, “camminando facciamo domande”, e nel libro Primavera zapatista esploro una serie di domande mentre scavo con i compagni una trincea lunga sette chilometri. In termini di solidarietà internazionale in Chiapas, si è trattato principalmente di consolidare l’autonomia del progetto zapatista e di sostenere la sua rivoluzione. Si tratta di lavorare insieme, fianco a fianco, con un obiettivo comune. Cerchiamo di raggiungere un senso di reciprocità – lavoriamo insieme per il mondo che vogliamo vedere. Questo implica che la solidarietà non è uno scambio a senso unico, ma un rapporto più paritario – e ognuno porta al tavolo ciò che può. Il concetto di reciprocità si allontana dalle connotazioni più paternalistiche della solidarietà per passare a una pratica di aiuto reciproco. La solidarietà non si misura in termini di lavoro svolto ma, al suo meglio, riguarda le relazioni e il diventare compagni, uguali, persone che si preoccupano davvero l’una dell’altra.
In realtà, la solidarietà è un esercizio disordinato ed esasperante. Sono stato coinvolto nel lavoro di solidarietà in Chiapas per quasi 15 anni e sono stato testimone di decine di progetti e centinaia di volontari che si davano da fare. Ci sono state innumerevoli iniziative e progetti brillanti che hanno fatto onore alla solidarietà nazionale e internazionale, dall’introduzione di sistemi di acqua potabile, alla fornitura di energia solare, a mezzi di comunicazione tecnologicamente appropriati, alla radio pirata, all’orticoltura biologica, fino a ciò che la maggior parte dei volontari ha finito per fare: rimanere negli accampamenti di pace nei villaggi e nelle frazioni rurali per monitorare gli attacchi militari messicani alle comunità indigene.
Naturalmente, ci sono state molte iniziative non riuscite e fallite, perché si trattava di un’esperienza di apprendimento e a volte la solidarietà si presentava in una forma che non era utile. Tra i volontari che vennero ad aiutare c’erano quelli che non riuscivano a liberarsi del loro ego e che facevano leva su se stessi, i tipi da salvatore bianco, e questo fu un problema. Sono arrivate altre persone con buone intenzioni che hanno portato con sé il bagaglio delle loro società e la zona autonoma è diventata un teatro per le loro disfunzioni.
Gli zapatisti hanno deciso, dopo circa 10 anni, di cambiare il paradigma e di assumere il controllo di tutti gli aspetti della solidarietà internazionale che arrivava nella regione. Hanno riconosciuto e lodato il coinvolgimento della solidarietà internazionale all’interno della zona ribelle – “coloro che sono nati su altre terre e che aggiungono il loro cuore alla lotta per una pace con giustizia e dignità”, secondo il Subcomandante Marcos – e hanno detto: “Grazie, ora ci pensiamo noi”.
Il principio di base era che nulla sarebbe stato imposto e nessuna decisione riguardante la solidarietà sarebbe stata presa senza il loro diretto coinvolgimento. Tutti gli esterni – comprese le ONG e i gruppi di sviluppo – furono d’ora in poi indirizzati ai Comitati di Buon Governo, con sede nei centri regionali di amministrazione dei ribelli chiamati caracoles. Lì presentavano le loro proposte e i loro progetti a commissioni indigene di autogestione composte da un gruppo di due uomini e due donne provenienti da comunità a rotazione.
Oltre alla solidarietà, gli zapatisti stavano piantando il seme dello zapatismo e incoraggiavano la gente a non limitarsi a sostenerli, ma a “essere zapatista ovunque si trovi”. Solidarietà come costruzione del movimento. Alla domanda su quale fosse il miglior contributo che gli internazionali potessero dare alla lotta zapatista, un vecchio zapatista di allora rispose: “Più Seattles”. Una versione più contemporanea sarebbe “Più rivolte di Black Lives Matter”.
Oltre ai progetti di solidarietà inutili o imposti, c’era anche il fatto che gli attivisti della solidarietà erano in una posizione molto meno vulnerabile rispetto alla popolazione del Chiapas in termini di rischi posti dallo Stato messicano, dai militari e da altre forze. Può parlare più dettagliatamente del riconoscimento di queste differenze di posizione e degli sforzi per sfidare gli assunti e i comportamenti coloniali da parte degli attivisti?
Dipende da chi è al comando, da chi ha il potere nella relazione. In Belize ho partecipato a una campagna per il riconoscimento sindacale dei lavoratori delle banane sfruttati. Gli organizzatori del sindacato sono stati minacciati e attaccati dai boss delle piantagioni di banane locali. Noi – alcuni visitatori irlandesi – abbiamo trascorso del tempo nei loro villaggi e abbiamo chiesto come potevamo aiutare. Tornati in Irlanda, siamo riusciti a ottenere un incontro con i proprietari delle aziende produttrici di banane, che si sono resi conto che questa esposizione era negativa per gli affari e hanno affrontato il problema. In senso lato, gli organizzatori sindacali hanno preso l’iniziativa, noi abbiamo risposto e il risultato è stato positivo. Naturalmente, in realtà è stato molto più complicato di così, ma di per sé il rapporto tra gli attori sul campo e la solidarietà internazionale è stato di aiuto reciproco.
In Chiapas è stato molto più complicato, perché gli zapatisti stavano portando avanti una rivoluzione per la terra e la libertà e migliaia e migliaia di benefattori si sono riversati nella regione. Nei primi anni, la solidarietà internazionale si trovava in un territorio un po’ selvaggio in termini di “tutto è permesso” e ogni sorta di progetto e iniziativa inappropriata è stata imposta alle comunità zapatiste sia dalle ONG che dagli attivisti. Il bagaglio che gli attivisti della solidarietà internazionale portavano con sé – in termini di atteggiamenti neocoloniali non riconciliati o semplicemente di problemi di salute mentale da primo mondo – creava sfide che richiedevano strategie diverse. Ma le comunità erano abbastanza forti e robuste da contrastare l’assalto e, come ho spiegato sopra, hanno preso il controllo della solidarietà attraverso i Comitati di Buon Governo a rotazione.
In termini di privilegi, le lotte prolungate come quella in Chiapas tendono a durare molti anni e gli attivisti della solidarietà internazionale vanno e vengono. “I campamentisti sono le persone che se ne vanno”, ha lamentato uno zapatista, “e noi non possiamo mai andarcene”. Questo è solo un altro privilegio di coloro che possono entrare in una zona di conflitto pericolosa per un tempo limitato e poi andarsene quando l’umore lo richiede. È uno struggente promemoria delle disuguaglianze intrinseche e ineluttabili, delle contraddizioni quasi insormontabili che ci sono all’interno e un motivo di comprensibile risentimento per alcuni che si trovano al centro di una lotta di vita o di morte.
Lei ha anche fatto parte di una delegazione di solidarietà che ha visitato brevemente le regioni curde in Turchia e in Iraq nel 1994, come descrive in Clandestini. Si trattava di un periodo di grave violenza nella repressione della rivolta curda da parte dello Stato turco e non molto tempo dopo il massacro di Halabja nel Kurdistan iracheno per ordine di Saddam Hussein. Lei è sembrato molto colpito dagli incontri di questo viaggio, ma ancora piuttosto distante dal tipo di politica marxista-leninista del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Come vede lo sviluppo del movimento dal momento di quella breve visita? Vede molti parallelismi tra il movimento curdo e le lotte che ha visto da vicino in America Latina?
Non credo che nessuno abbia previsto lo straordinario passaggio ideologico da un’organizzazione verticistica con una fissazione sulla leadership a un confederalismo femminista ed ecologico più contemporaneo, con molta meno enfasi su Abdullah Öcalan. È un merito assoluto della leadership e della base del movimento aver saputo abbracciare e attuare efficacemente i cambiamenti degli anni 2000, lottando contemporaneamente su tutti i fronti. E non c’è alcun dubbio sulla sincerità degli sforzi per raggiungere queste aspirazioni democratiche partecipative – la prova del comunitarismo curdo è presente sul campo non solo in Rojava, ma anche nel territorio curdo della Turchia sudorientale.
Non ho molto da dire che sia rilevante oggi come lo era nel 1994, quando camminavamo con i compagni sulle montagne dell’Iraq settentrionale, ma voglio fare un’osservazione. I cinici dicono che i curdi enfatizzano eccessivamente il ruolo delle donne nella lotta armata per placare lo sguardo liberale/femminista “occidentale” – Hilary Clinton ne è una fan – ma allora, quando nessuno guardava ai curdi, incontravamo gli stessi battaglioni femminili in prima linea. In questo senso, elementi dell’ideologia evoluta di oggi erano già nascenti 25 anni fa, come è ben documentato.
Molti antiautoritari, d’altra parte, vedono un problema nella venerazione dei curdi per il leader del PKK imprigionato, Abdullah Öcalan. Se da un lato l’idolatria di Öcalan è sconcertante, dall’altro, in termini di potere reale, è chiaro che egli non dirige più un’organizzazione così verticistica e che il processo decisionale si è decentralizzato. Mi piace pensare che la rappresentazione iconica di Öcalan sia in evoluzione, allontanandosi lentamente da Stalin e avvicinandosi a Durruti.
La lotta curda – e il Rojava in particolare – rappresenta in primo luogo una comunità e un popolo che osano prefigurare un altro mondo, un’altra società basata sull’uguaglianza e sulla giustizia; e in secondo luogo, come la zona autonoma zapatista, un territorio in resistenza che ci permette di immaginare l’impossibile. Sostengo pienamente la campagna in difesa della rivoluzione del Rojava, nel nord della Siria. Le Brigate Internazionali di Lavoro, organizzate dalla Comune Internazionalista del Rojava, sono un esempio ammirevole di solidarietà internazionale in azione. Il loro slogan di lavoro – “Veniamo qui per imparare, sostenere, organizzare” – sintetizza una buona pratica di solidarietà.
Quali sono, a suo avviso, le principali sfide o opportunità in Occidente in termini di costruzione e sostegno della lotta internazionalista oggi? Intendo dire la capacità di impegnarsi criticamente con i movimenti altrove e di sostenerli, costruendo al contempo il potere dove siamo.
All’interno della Fortezza Europa ci sono diverse basi territoriali di quello che potrebbe essere meglio descritto come contropotere. L’esempio migliore è ad Atene, dove il quartiere ribelle di Exarchia ospita una grande comunità di radicali greci e internazionali. Qui portano la solidarietà internazionale a un altro livello. Gli abitanti hanno creato una struttura di quartiere per offrire sostegno ai rifugiati e ai migranti e non c’è separazione: vivono insieme, mangiano insieme e lottano insieme. Gli attivisti hanno occupato edifici per dare rifugio a chi ne aveva bisogno, il cibo viene distribuito da vari centri sociali gestiti da anarchici e autonomisti, ci sono iniziative gratuite per la salute e l’istruzione e le risorse vengono condivise all’interno della comunità.
Camminando per Exarchia o parlando con i compagni, si percepisce un senso palpabile di solidarietà quotidiana – non solo con i rifugiati e i migranti, ma anche per i movimenti sociali e politici globali che hanno sede nel quartiere, dai curdi ai palestinesi. Le manifestazioni antifasciste possono mobilitare migliaia di persone e la polizia non è mai la benvenuta nel barrio: in genere appare solo in bande intimidatorie in motocicletta.
Per anni, Exarchia è stata un centro vivo e pulsante di contropotere nel nucleo imperialista, impegnato a sostenere gli sviluppi della periferia in modo reciproco. Ed è proprio la minaccia del buon esempio il motivo per cui devono affrontare un’implacabile repressione statale. Ora, a causa della rapida gentrificazione dell’area – stimolata dai piani per una nuova stazione della metropolitana proprio nel cuore di Piazza Exarchion – e della dilagante mercificazione degli spazi abitativi tramite Airbnb, può sembrare un territorio sotto assedio. Ma Exarchia resiste e, nonostante gli sgomberi di diversi squat dal 2019, i fondamenti rimangono al loro posto.
Exarchia non è eccezionale, ci sono basi di alternative antisistemiche in tutta Europa, anche se su scala minore e in forme diverse. Ho assistito a progetti autonomi analoghi, ad esempio, nel quartiere di Connewitz a Lipsia o a Vallekas a Madrid. Christiania, a Copenaghen, è un’altra cosa – più una comunità intenzionale – ma condivide tratti simili. Il fattore comune è il desiderio di creare iniziative comunitarie e non capitalistiche che riuniscano le persone e favoriscano l’aiuto reciproco.
Il Viaggio per la Vita degli zapatisti, l’anno scorso, è servito a tessere un arazzo di ribellione, radunando e riunendo collettivi e organizzazioni in tutta Europa. Questi sono giorni bui in Europa, con l’ascesa dell’estrema destra, la crisi climatica, la pandemia e la grave disuguaglianza. I nodi antisistemici rappresentano un’alternativa radicale e un raggio di speranza. Parafrasando il Che, abbiamo bisogno di uno, due, tre, cento territori ribelli come il Chiapas.
Oltre ad aver vissuto per molti anni in America Latina, lei ha tradotto diversi libri sui movimenti sociali di diversi Paesi: tre di Raúl Zibechi e, più recentemente, uno di Luis Hernández Navarro. Per cominciare con Zibechi, quali sono, secondo lei, gli insegnamenti principali che si possono trarre dalla lettura del suo lavoro e dei movimenti in cui è impegnato?
Raúl Zibechi è uno dei principali teorici politici dell’America Latina ed è stato attivo contro la dittatura militare in Uruguay negli anni Settanta. Come investigatore militante, ha trascorso la sua vita lottando a fianco e analizzando i movimenti sociali in formazioni nuove ed emancipatrici – quelle che lui definisce società in movimento – in conflitto con lo Stato neocoloniale e neoliberale.
In Territori in resistenza: A Cartography of Latin American Social Movements (2012), si concentra su attori antisistemici e non statali in tutto il continente, dagli zapatisti del Chiapas ai mapuche del Cile, dove l’emancipazione non è solo l’obiettivo ma il processo di lotta quotidiano. Si tratta di nuove formazioni sociali uniche, basate nelle campagne, come il Movimento dei lavoratori senza terra in Brasile, o nelle comunità indigene urbane, come nella città di El Alto, in Bolivia, che l’autore esplora in dettaglio in Dispersing Power: Social Movements as Anti-State Forces (2010). Sono caratterizzati da relazioni sociali non capitaliste ed esistono di fatto come resistenza allo Stato neoliberale.
Zibechi considera lo Stato in America Latina come una costruzione neocoloniale e intrinsecamente oppressiva. In Il nuovo Brasile: Regional Imperialism and the New Democracy (2014) critica l’amministrazione di sinistra di Lula e del Partito dei lavoratori brasiliano. Nonostante alcune riforme politiche, l’affidamento del governo Lula alle politiche estrattiviste, alle miniere, alla monocultura e alle megadighe rivela la sua fondamentale logica capitalista e neocoloniale, che descrive come una forma di sub-imperialismo regionale.
La sua critica incrollabile allo Stato e in particolare alle amministrazioni di sinistra – la cosiddetta Marea Rosa in America Latina – include Evo Morales e il governo del Movimento verso il Socialismo (MAS) in Bolivia. Per Zibechi, le politiche extracastavistiche di Morales e il tradimento dei movimenti sociali di base indicavano che era giunto il momento di andarsene dopo 14 anni di potere. Ha sostenuto la mobilitazione popolare di massa del 2019 per deporre Morales, ma ha condannato il successivo colpo di Stato della destra guidata dai militari.
Tuttavia, la sua posizione antistatale ha portato ad accuse errate da parte dei sostenitori della sinistra di Morales di aver appoggiato il golpe della destra. Zibechi ha sostenuto i movimenti anti-sistemici contro la sinistra istituzionalizzata, ma ha fatto una chiara distinzione tra i movimenti che provengono dal basso e dalla sinistra e quelli, come nel caso del golpe boliviano sostenuto dall’élite, che provengono dall’alto, cioè tra oppressi e oppressori. L’incidente ha messo in luce una grande spaccatura a sinistra tra statalisti e antiautoritari in America Latina e non solo.
La critica di Zibechi ai partiti di sinistra al potere può essere applicata anche al contesto europeo, con il fallimento del governo di Syriza in Grecia o la deludente performance di Podemos nello Stato spagnolo. Come è accaduto in Brasile con Lula e il Partito dei Lavoratori, la cooptazione delle forze sociali e politiche ribelli è stata una strategia utilizzata dalle amministrazioni di sinistra per neutralizzare i forti movimenti sociali di base.
La sua traduzione più recente è il libro Self-Defense in Mexico: Indigenous Community Policing and the New Dirty Wars (2020) di Luis Hernández Navarro. So che è un’altra opera di cui è molto entusiasta. Perché è un’opera così importante secondo lei? In un momento in cui sempre più persone si interessano all’abolizione e ai modelli alternativi di giustizia, quali lezioni si possono trovare in questo libro?
Luis Hernández Navarro è uno dei più noti scrittori e giornalisti di sinistra in Messico e in Autodifesa in Messico ripercorre la risposta dei movimenti sociali messicani alla minaccia del narcoterrorismo. Diverse regioni dello Stato messicano sono state invase da potenti cartelli della droga e sommerse dalla violenza e dal terrore. I movimenti sociali in questi territori assumono la forma di autodifesa in tempo di guerra.
Luis Hernández porta il lettore nelle comunità rurali, spesso indigene, degli Stati di Michoacán e Guerro e di altre parti del Messico dove la narco-guerra è prevalente e presenta il conflitto dal loro punto di vista. Queste città e questi villaggi isolati vengono calpestati dai cartelli in collusione con i funzionari statali e le forze di sicurezza e, se si alzano in piedi e si difendono, rischiano di essere annientati. È uno scenario desolante, ma con storie di grande coraggio e resilienza comunitaria.
In termini di lezioni sull’abolizione della polizia e sulle forme alternative di giustizia, Luis Hernández sottolinea innanzitutto le diverse forme di autodifesa che assumono queste comunità. Esistono differenze nette tra la polizia cittadina o comunitaria e i gruppi di autodifesa dei vigilanti. La polizia comunitaria è radicata nelle comunità indigene e nominata dagli organi di autogoverno delle comunità stesse. La polizia comunitaria è responsabile nei confronti della comunità e in genere i suoi incarichi sono a rotazione – parte di un sistema tradizionale di lavoro comunitario. D’altra parte, le autodifese, o autodefensas, sono una reazione a una minaccia armata proveniente dall’esterno e sono formate da singoli elementi armati provenienti da diversi strati della società – dai ricchi allevatori ai raccoglitori di frutta. Non sono governate dalle comunità che proteggono.
Modelli come il Comitato Regionale di Coordinamento delle Autorità Comunitarie (CRAC), con sede a Guerrero, un’organizzazione di polizia auto-organizzata che abbraccia decine di piccoli villaggi e frazioni rurali emarginate, sono utili per imparare dalle esperienze di polizia comunitaria e immaginare una forma diversa di contratto sociale. Queste reti autonome fanno parte del processo in atto in tutto il Messico di recupero da parte delle comunità indigene dei loro costumi e delle loro pratiche tradizionali.
Sebbene questi modelli possano essere specifici della situazione messicana, vi sono alcune sorprendenti analogie con l’abolizione della polizia e le forme alternative di giustizia in altri contesti. Storicamente, le Pantere Nere, ad esempio, sono nate come gruppo di autodifesa e hanno assunto una sorta di struttura di polizia comunitaria. Gli scritti teorici di Huey Newton sull’intercomunalità anticipano la prassi non solo della polizia comunitaria indigena di Guerrero, ma anche degli zapatisti.
Una parte importante del lavoro di Luis Hernández espone come lo Stato utilizzi il pretesto della guerra alla droga per attaccare i movimenti sociali, come nel caso tristemente noto della sparizione e dell’assassinio dei 43 studenti di Ayotzinapa, Guerrero, nel 2014. Inizialmente dipinto come un massacro del cartello, i difensori dei diritti umani hanno dimostrato la complicità dei politici e dei capi della sicurezza del Guerrero.
Allo stesso modo, ci offre una visione della vita e della morte di attivisti dei movimenti sociali come Rocio Mesina, salita alla ribalta dopo il massacro di Aguas Blancas del 1995, quando le forze di sicurezza aprirono il fuoco sui contadini che si recavano a una manifestazione in Guerrero, uccidendo 17 persone. Rocio è sopravvissuta, ma ha perso diversi familiari nell’attacco.
Nell’ambito della nostra iniziativa di solidarietà internazionale, Rocio è venuta a Dublino nel 1996 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla repressione dello Stato in Guerrero. Luis Hernández racconta la storia e il contesto dell’omicidio di Rocio, avvenuto nel 2013 per mano di un sicario mentre difendeva la sua comunità indigena. L’omicidio è stato fatto passare per un’altra morte legata al narcotraffico, ma le indagini dei difensori dei diritti umani hanno portato alla luce le prove che il governatore dello Stato aveva ordinato l’assassinio.
Infine, a proposito di compagni perduti, Liam ha detto di far parte di un gruppo di lettura per L’alba di tutto di David Graeber e David Wengrow. Le dispiace se parlo di David Graeber a Genova, nel 2001, una sorta di elogio?
La prego di farlo.
David e io ci siamo trovati in prima fila nella grande manifestazione il giorno dopo l’omicidio di Carlo Giuliani da parte della polizia. Quando il corteo si è trasformato in un’ampia passeggiata in riva al mare, le schiere di poliziotti in assetto antisommossa che bloccavano il percorso hanno iniziato a sparare raffiche di gas lacrimogeni. Tra il panico e il caos, David si occupò di raccogliere i candelotti fumanti di gas lacrimogeno e di lanciarli lontano dalla folla. Non avendo un grande braccio da lancio, sapeva di non poterli scagliare contro le linee di polizia, ma ha capito che poteva lanciarli in modo sicuro di lato, nell’oceano e lontano dalla gente.
L’ho perso quando la polizia ha caricato e so che David ha vissuto un momento traumatico uscendo da Genova mentre le autorità davano la caccia ai manifestanti, ma è così che mi piace ricordarlo: mentre si muoveva in prima linea, lanciando gas lacrimogeni nell’oceano. Sono sicuro che c’è una sorta di metafora in questo, certamente rivela un lato del suo carattere che la gente potrebbe non conoscere.
Articolo originale: https://roarmag.org/essays/ramor-ryan-interview/